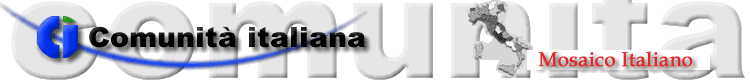
“Anziosi di andare alla caccia del selvaggio”Paolo Spedicato
È merito dello storico veneziano Piero Brunello aver contribuito a rinnovare gli studi sulla nostra emigrazione storica nel Brasile meridionale con questo libro di dieci anni fa, incentrandolo sul “mito della frontiera” e dei pionieri italiani, elemento base per l’esercizio di molto saudosismo in circolazione a partire dal centenario dell’emigrazione italiana celebrato nel 1975. Stiamo parlando di Pionieri. Gli italiani in Brasile e il mito della frontiera. (Roma: Donzelli, 1994).
Preceduti solo dagli emigranti tedeschi tra 1825 e 1850, gli italiani fondarono colonie tra il 1875 e il 1915, dapprima vicino alla costa a nord di Florianopolis, Blumenau, Brusque, Nova Trento, e progressivamente verso sud, Grão Pará, Urussanga, Criciuma, e sud ovest, Caxias do Sul (la vecchia Campo dos Bugres), Nova Trento, Nova Milano… Le storie di emigrazione italiana qui trattate (statisticamente si parla di 54 per cento di origine veneta, 33 per cento lombarda, 7 per cento trentina e 4,5 per cento friulana), hanno per protagonisti tre soggetti: i bugres, i bugreiros e i coloni italiani propriamente detti. Spregiativamente chiamati bugres o selvaggi, in realtà si trattava di popoli indigeni nomadi dell’altopiano riograndense, i Kaingang, e della Serra di Santa Catarina, questi ultimi particolarmente isolati, gli Xokleng, chiamati anche i terribili Botocudos, dal caratteristico labbro inferiore dilatato per via di un pezzo di legno o botoque. Nei documenti ufficiali e nell’opinione pubblica li si contrapponeva solitamente agli indios “ammansiti”, ai Guarani, che avevano accettato la civiltà europea e la catechesi cristiana dopo secoli di contatti con i padri gesuiti. Brunello, sulla scorta di altri storici affermati quali Emilio Franzina, Mario Sabbatini, la brasiliana Teresa Isenburg, e un controllo scientifico di fonti d’epoca scritte e orali, confronta i comportamenti e i simbolismi dei due campi contrapposti, indios e coloni, affermando che i primi“Uccidevano molto raramente, e solo per vendetta… Col tempo, perfino la ‘Blumenauer Zeitung’, un giornale in lingua tedesca di Blumenau che predicava l’annientamento degli indiani, avrebbe riconosciuto che i Botocudos attaccavano le case solo per rubare accette di ferro, che se gridavano e tiravano frecce e pietre contro le capanne lo facevano per consentire agli abitanti di mettersi in salvo, e che avevano cominciato a uccidere soltanto dopo la morte di uno di loro. Ma i coloni, se gli indiani si avvicinavano alle case per curiosare, li ammazzavano sparando col fucile” (p. 11). I coloni non sembravano gradire le simulazioni dei nativi né i furti di utensili o cibo.
Due culture si contrapponevano inesorabilmente, il nomadismo silvestre contro lo stanzialismo agricolo degli insediamenti previsti dagli ingegneri della Compagnia di Colonizzazione governativa o anche di qualche società privata italiana, come quella del direttore di colonia, il palermitano Michele Napoli, “che ottenne trentamila ettari ai piedi della Serra a prezzi irrisori” (p. 17). I presupposti per una epopea tragica e sanguinaria erano già tutti presenti. Nel furto degli attrezzi di metallo e delle pentole della vita quotidiana dei coloni ad opera degli indios c’era l’individuazione degli strumenti della colonizzazione che attraverso il disboscamento sistematico andava a distruggere il loro habitat e la loro cultura. Già nel 1856 il dottor Hermann Blumenau chiedeva al governo della provincia l’invio di soldati atti a implementare “una disinfezione completa” del territorio. Questo linguaggio da “soluzione finale” non deve meravigliare e va riportato al progetto di massima del governo centrale di “branquear” il paese tramite l’influsso della emigrazione di origine europea e al generale clima di razzismo e di paura nei confronti di quei diversi che rifiutavano l’integrazione e la radicale trasformazione del territorio: “del resto, anche se si avvicinavano alle colonie solo di notte e mai per uccidere, rubavano ‘come serpenti’, ed era impossibile convertirli al cristianesimo” (p. 13), come scrivevano i giornali di Santa Catarina annunciando le spedizioni di bugreiros o cacciatori di indios.
All’arrivo degli italiani, le spedizioni contro i villaggi indigeni facevano parte della norma. Un mantovano scriveva ai fratelli in Italia d’essere stato ben ricevuto da “quei cristiani e molto più timorati di Dio che in Italia”, di non aver contratto debiti col governo, anzi di aver ricevuto “una mancia” con la quale avevano comperato le armi “ansiosi di andare alla caccia del selvaggio”, ed erano poi andati a caccia “non sono [si legga: solo] delle bestie feroci ansi dei buoni selvaggi” (p. 31) Lettera da Brusque, 29 settembre 1876). (continua – I)
Mosaico Italiano #15

"Anziosi di andare alla caccia del selvaggio" (Paolo Spedicato)
Commento alla traduzione di "Quel giorno a Madrid" e "I giusti" di Raffaele Ibba (Cristiana Cocco)
Lingua, Cultura e Didattica Oggi (Paola Micheli)
Boccaccio & Pasolini: La lettura dei classici (Maria Celeste Tommasello Ramos)
Requiem: un incontro tra Alain Tanner, Antonio Tabucchi e Fernando Pessoa (Patricia Peterle)
I Simposio di Studi Linguistici dell'Italiano:
Proposta di elaborazione di dizionario didattica (Paola Baccin)
Genesi ed esito del manuale didattico "Impariamo l'Italiano" (Mauro Porru)
Come possiamo difernderci da chi ci ruba energie (Francesco Alberoni)