
L'eredità viscontiana
Alessandro Bencivenni
Quando accade che la critica giornalistica adoperi per qualche film l’appellativo di “viscontiano”, lo fa ancor oggi riferendosi a elementi esteriori, come il compiacimento per il lusso o l’ambientazione scenografica minuziosa.
Tutto ciò perpetua un luogo comune che Visconti stesso stigmatizzava: “Le solite banalità: Visconti vuoi fare il film fastoso, il film gradevole da vedere, il film interpretato da gente bella, il film di lusso, il film che mal che vada si regge sempre per l’arredamento e i costumi” .
Il vero Visconti va ricercato piuttosto nei temi e nello stile: nella predilezione per il melodramma, nel racconto delle trasformazioni storiche attraverso la sconfitta dei destini individuali. In questo senso, non sono molti i film che meritino davvero l’appellativo di viscontiano.
Il primo posto in questa breve e certo incompleta rassegna spetta cronologicamente a quelli che furono gli aiutoregisti de La terra trema: Francesco Rosi e Franco Zeffìrelli.
La critica di un tempo usava contrapporre un Visconti “realista” a un Visconti “decadente”, mentre oggi si preferisce considerare i due termini integrati e compresenti in un costante rapporto dialettico.
Invece, nell’opera di Rosi e Zeffirelli, è come se i due termini sopravvivessero scissi. Visconti ha infatti trasmesso al primo il gusto per l’affresco sociale, all’altro quello per la messinscena melodrammatica.
Rosi ha proseguito con successo sulla strada del meridionalismo e dell’impegno civile, concedendosi nel 1984 una fortunata incursione nel film-opera con una Carmen in chiave verista. Zeffirelli ha trovato invece nel teatro e nel melodramma costante alimento anche per la sua attività cinematografica, grondante di languori e di manierismi formali.
Opposte carriere, come opposta fu la considerazione che il maestro dimostrò per loro: verso Rosi, Visconti ebbe ripetute parole di stima, mentre al secondo riservò via via apprezzamenti sempre più caustici:
Rosi ha avuto uno sviluppo particolare. Non lo considero più un giovane. E una affiliazione diretta (1963).
Zeffirelli? Un ragazzino che poteva venir su mica male, ma s’è guastato per strada e talvolta ha delle vanità così sciocche, così femminili... Gli ho anche telefonato. Gli ho detto: sei peggio della Taylor... (1974).
Effettivamente, nelle regie manierate e accademiche di Zeffirelli c’è più inclinazione al presepe vivente che alla lettura critica dei testi che mette in scena.
Mentre in Visconti è proprio l’approccio critico verso il mondo che ricostruisce e interpreta a dare sostanza e vitale contraddizione al suo modo di rappresentarlo. E una questione di stile, ma anche una scelta ideologica: e le opposte vedute in questo campo furono uno degli elementi che allontanarono i due registi. Così come nella “affiliazione” di Rosi ebbe senz’altro peso la comunanza delle posizioni politiche.
Oggi, con la crisi delle ideologie, può apparire datata e ambigua la professione di fede comunista dell’aristocratico Visconti. Ancor più di quanto - lui vivo - già non sconcertasse vedere sul set questo compagno-regista che esigeva di esigeva di essere chiamato “signor conte”.
Eppure, se si toglie ai suoi film la contraddizione tra il progresso e la nostalgia, tra il solipsismo e la fede sociale, tra l’amore per la cultura decadente e il tentativo di storicizzarla, si perde il senso diciò che è autenticamente viscontiano.
Ha detto bene Renzo Renzi nel recente “Visconti segreto”: “II cinema e il teatro furono, per lui, l’occasione di un lungo godimento estetico, quindi di una lunga liberazione, ma insieme anche di una lunga, molto civile, espiazione”. Tutta la sua opera è attraversata infatti da un profondo senso di colpa, legato alla sua duplice “ diversità” di omosessuale e di aristocratico, vissuta contemporaneamente come privilegio e come condanna.
L’espiazione di cui parla Renzi passa anche per la politica. Le scelte di Visconti in questo campo sono certo contraddittorie, ma inscindibili dalle sue scelte poetiche. Con buona pace di quanti oggi vogliono fare di lui una specie di vessillo della cultura di destra.
Bisogna ammettere però che l’atteggiamento di Visconti nei confronti degli autori delle generazioni più giovani fu molto conservatore.Cinema Antropomorfico
Luchino Visconti
Che cosa mi ha portato ad una attività creativa nel cinema?
(Attività creativa: opera di un uomo vivente in mezzo agli uomini.Con questo termine sia chiaro che mi guardo bene dall’intendere qualcosa che si riferisca soltanto al dominio dell’artista. Ogni lavoratore, vivendo, crea: sempre che egli possa vivere. Cioè: sempre che le condizioni della sua giornata siano libere e aperte; per l’artista come per l’artigiano e l’operaio).
Non il richiamo prepotente di una pretesa vocazione, concetto romantico lontano dalla nostra realtà attuale, termine astratto, coniato a comodo degli artisti, per contrapporre il privilegio della loro attività a quella degli altri uomini.
Poiché la vocazione non esiste, ma esiste la coscienza della propria esperienza, lo sviluppo dialettico della vita di un uomo al contatto con gli altri uomini, penso che solo attraverso una sofferta esperienza, quotidianamente stimolata da un affettuoso e obiettivo esame dei casi umani, si possa giungere alla specializzazione.
Ma giungere non vuoi dire rinchiudersi, rompendo ogni concreto legame sociale, come a molti accade, al punto che la specializzazione finisce sovente col prestarsi a colpevoli evasioni dalla realtà, e in parole più crude: al trasformarsi in una vile astensione.
Non voglio dire che ogni lavoro non sia lavoro particolare e in un certo senso “mestiere”. Ma sarà valido solo se sarà il prodotto di molteplici testimonianze di vita, se sarà una manifestazione di vita.
II cinema mi ha attirato perché in esso confluiscono e si coordinano slanci e esigenze di molti, tesi per un lavoro complessivo migliore. E chiaro come la responsabilità umana del regista ne risulti straordinariamente intensa, ma, purché egli non sia corrotto da una decadentistica visione del mondo, proprio da essa verrà indirizzato sulla strada più giusta.
Al cinema mi ha portato soprattutto l’impegno di raccontare storie di uomini vivi: di uomini vivi nelle cose, non le cose per se stesse.
Il cinema che mi interessa è un cinema antropomorfico. Di tutti i compiti che mi spettano come regista, quello che più mi appassiona è dunque il lavoro con gli attori; materiale umano con il quale si costruiscono questi uomini nuovi, che, chiamati a viverla, generano una nuova realtà, la realtà dell’arte.
Perché l’attore è prima di tutto un uomo. Possiede qualità umane-chiave. Su di esse cerco di basarmi, graduandole nella costruzione del personaggio: al punto che l’uomo-attore e l’uomo-personaggio vengano ad un certo punto ad essere uno solo.
Fino ad oggi, il cinema italiano ha piuttosto subito gli attori, lasciandoli liberi di ingigantire i loro vizi e le loro vanità: mentre il problema vero è quello di servirsi di ciò che di concreto e di originario essi serbano nella loro natura.
Perciò importa fino a un certo grado che attori cosiddetti professionali si presentino al regista deformati da una più o meno lunga esperienza personale che li definisce in formule schematiche, risultanti di solito più da sovrapposizioni artificiose che dalla loro intima umanità.
Anche se molto spesso è una dura fatica, quella di ritrovare il nocciolo di una personalità contraffatta e una fatica che tuttavia vale la pena di spendere: proprio perché al fondo una creatura umana c’è sempre, liberabile e rieducabile.
Astraendo con violenza dagli schemi precedenti, da ogni ricordo di metodo e di scuola, si cerchi di portare l’attore a parlare finalmente una sua lingua istintiva. Si intende che la fatica non sarà sterile, solo se questa lingua esiste sia pure involuta e nascosta sottocento veli: se esiste cioè un vero “temperamento”.
Non escludo, naturalmente, che un “grande attore” nel senso della tecnica e dell’esperienza, possegga tali qualità primitive. Ma voglio dire che, spesso, attori meno illustri sul mercato, ma non per questo meno degni di attirare la nostra attenzione, ne posseggono altrettante.
Per non parlare dei non attori, che, oltre a recare il contributo affascinante della semplicità, spesso ne hanno di più autentiche e di più sane, proprio perché, come prodotti di ambienti non compromessi, sono spesso uomini migliori. L’importante è scoprirle e metterle a fuoco. Ecco dove è necessario intervenga quella capacità rabdomantica del regista, tanto nell’uno come nell’altro caso.
L’esperienza fatta mi ha soprattutto insegnato che il peso dell’essere umano, la sua presenza, è la sola “cosa” che veramente colmi il fotogramma, che l’ambiente è da lui creato, dalla sua vivente presenza, e che dalle passioni che lo agitano questo acquista verità e rilievo; mentre anche la sua momentanea assenza dal rettangolo luminoso ricondurrà ogni cosa a un aspetto di non animata natura.
Il più umile gesto dell’uomo, il suo passo, le sue esitazioni e i suoi impulsi da soli danno poesia e vibrazioni alle cose che li circondano e nelle quali si inquadrano. Ogni diversa soluzione del problema mi sembrerà sempre un attentato alla realtà così come essa si svolge davanti ai nostri occhi: fatta dagli uomini e da essi modificata continuamente.
Il discorso è appena accennato, ma accentrando il mio netto atteggiamento, vorrei concludere dicendo (come spesso amo ripetermi): potrei fare un film davanti a un muro, se sapessi ritrovare i dati della vera umanità degli uomini posti davanti al nudo elemento scenografico: ritrovarli e raccontarli.
Una sera di metà gennaio, a Roma, entrai al teatro Valle per salutare i miei attori. Era quasi mezzanotte, e attraverso l’alto-parlante dei camerini sentii Rina Morelli che diceva l’ultima battuta di Liubòv Andrèievna: “Mi sembra di non aver mai visto prima d’ora i muri e i soffitti di questa casa...”.
Anche quella sera, a due mesi e mezzo dalla prima rappresen-tazione, II giardino dei ciliegi aveva fatto un “tutto esaurito”. In salac’erano moltissimi giovani. E oltre alla solita quota di abbonati alla stagione del nuovo Stabile c’era evidentemente un pubblico insolito per il teatro di prosa. Più che al Valle, sembrava di essere in una sala cinematografica di seconda visione, strapiena.
Sulla scena, i personaggi scomparivano a uno a uno, finché rimase solo il vecchio Firs e il sipario si chiuse: applausi interminabili come a un debutto, ma forse meno accondiscendenti e certo più spontanei di quelli che di solito vengono tributati dal pubblico delle “prime”. Contai più di quindici chiamate.
Ero soddisfatto come autore della messinscena, ma soprattutto ero divertito come vecchio osservatore di fatti teatrali. Eravamo ormai alla fine del periodo concessoci dal programma dello Stabile e il botteghino era ancora costretto, ogni sera, a respingere richieste di biglietti. Molta gente che desiderava vedere lo spettacolo, a Roma, non è riuscita a vederlo.
Con un totale di settantasette repliche e oltre settantamila spettatori paganti, Il giardino ha così smentito la sua assurda leggenda.Lo spendore di Visconti e il cinema contemporaneo italiano a Salvador
Mauro Porru
Dal 25 agosto al primo settembre 2002 ha avuto luogo a Salvador il Festival di cinema italiano intitolato “Luchino Visconti e il cinema nuovo italiano”. Questa iniziativa è frutto della collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo con l’Università Federale di Bahia, la “Diretoria de Imagem e de Som” della “Fundação Cultural do Estado da Bahia” e la “Fundação Gregorio de Mattos” del Comune di Salvador. Si è trattato in effetti di portare nella capitale baiana una parte della Mostra di cinema italiano avvenuta a San Paolo dal 14 al 23 agosto scorso, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura, dalla “Secretaria Municipal de Cultura”, dal “Centro Cultural”, della città di San Paolo, dal NICE (New Italian Cinema Events), dalla Cineteca Nazionale di Roma e dal Cinusp Paulo Emilio. Durante la Mostra, per commemorare i 26 anni della morte del grande regista milanese, è stata esibita integralmente tutta la filmografia viscontiana, con copie restaurate, e sono state presentate varie opere del cinema contemporaneo italiano, con la presenza di registi e attori. A Salvador sono giunti sette film della vasta e preziosa cinematografia viscontiana e cinque film di nuovi registi italiani. Così il pubblico baiano ha potuto assistere al felice incontro del regista milanese con la “diva” Anna Magnani che in Bellissima ci offre un magnifico ritratto di donna e di madre disposta ad affrontare ogni sorta di sacrificio pur di lanciare nel cinema la sua figlioletta Maria, per poi rendersi conto di quanto fossero sbagliate le sue ambizioni, vedendo la piccola diventare lo zimbello di insensibili cinematografari, emblematiche rappresentazioni di quanto possa essere crudele il mondo dello spettacolo. Le sontuose immagini di Senso hanno sbalordito spettatori attenti che hanno seguito affascianati le tragiche vicende della contessa veneziana Livia Serpieri, interpretata magistralmente da una stupenda Alida Valli, che, sullo sfondo della terza guerra d’ indipendenza, per amore del giovane tenente austriaco Franz Mahler, tradisce il marito e la patria. Tratto dalla novella omonima di Camillo Boito, il terzo lungometraggio di Visconti, del ’54, considerato dalla maggior parte dei critici il suo capolavoro, è di una bellezza figurativa eccezionale. Al cromatismo impareggiabile di Senso, ha fatto seguito il drammatico uso del bianco e nero di Vaghe stelle dell’Orsa, un film che porta sullo schermo il profondo conflitto morale e esistenziale di due fratelli, oppressi dai fantasmi di un passato in cui si intrecciano storie di incesto, assassinio e delazione. Ha fatto parte del Festival anche la trilogia tedesca, rappresentatata da: La caduta degli dei, un film in cui Visconti affronta il tema dell’ascesa del nazismo, nella Germania del 1933, raccontando la degenerazione materiale e spirituale di una potente famiglia di industriali dell’ acciaio che aderisce all’ideologia hitleriana; Morte a Venezia, basato sulla novella “La morte a Venezia” di Thomas Mann, in cui il problema dell’amore e dell’arte, della precarietà della bellezza e dell’imminenza della fine è trattato con squisita sensibilità e struggente partecipazione che la musica di Mahler commenta alla perfezione; Ludwig: uma biografia romanzata del folle re di Baviera, amante delle arti e della musica che utopicamente cercò di trasformare lo Stato Etico in Stato Estetico. La rassegna di Visconti si é chiusa con la proiezione del suo ultimo film L’innocente che, basato sul romanzo omonimo di Gabriele D’Annunzio, ritratta ancora una volta, con raffinata fastosità, un dramma familiare estremo segnato dall’infaticidio e dal suicidio. Hanno fatto parte del Festival, come è stato accennato prima, anche alcuni film contemporanei. La sera dell’ apertura è stato proiettato il primo lungometraggio di Andrea Porporati, un giovane scrittore-regista che ha pubblicato con la Mondadori due romanzi di successo: La felicità impura, nel 1990 e Nessun dolore, nel 1993. Nell’ambito del cinema, ha scritto le sceneggiature del film Stato di emergenza di Carlo Lizzani; del premiatissimo Lamerica di Gianni Amelio e di Vite in sospeso di Marco Turco. Per la televisione ha sceneggiato le miniserie La piovra 7, 8 e 9. Come regista ha diretto, nel 1999, il cortometraggio Quello che posso permettermi, premiato in “Anteprima anno zero - Bellaria Festival 2000”. Tra il 2000 e 2001 ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio intitolato Il sole negli occhi che ha ottenuto il “Grand Prix” e il premio internazionale dei cinema “d’essai” al Festival di Annecy 2001. Il film tratta di uno di quei crimini inspiegabili che la stampa definisce di “pazzia momentanea”. Marco, un ragazzo borghese benestante del Nord Italia, uccide suo padre accecato da un odio incomprensibile che cova da anni. Un trauma, uno shock del passato l’ha trasformato ed è parzialmente responsabile del delitto. Il giovane però non sa esattamente perché ha commesso quell’assassinio. L’incontro con una vicina di stanza, nell’alberghetto in cui si è rifugiato dopo l’omicidio e di cui si innamora, segna l’inizio di una profonda crisi e la possibilità di aprire gli occhi per capire il vero motivo che l’ha spinto a compiere il delitto, un motivo intimamente radicato nella sua personalità e nel suo passato ma che stenta a comprendere. Costruito dal punto di vista del giovane assassino, il film descrive con molta crudezza ma allo stesso tempo con molta umanità il percorso di questo dramma esistenziale. Interpreta magistralmente il giovane parricida Fabrizio Gifuni, un attore di grande talento, proveniente dal teatro, che dal 1996 lavora nel cinema, interpretando film di vario genere come Così ridevano di Gianni Amelio, vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia, nel ’98, Il Partigiano Johnny di Guido Chiesa, Hannibal di Ridley Scott, Un amore e Qui non è il Paradiso di Gianluca Tavarelli e L’amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci. Gifuni ha vinto vari premi tra cui, nel 2002, i più prestigiosi in ambito europeo: lo “Shooting Star” al Festival di Berlino e il “Globo d’oro” della stampa straniera. Oltre al Sole negli occhi, sono stati proiettati durante il Festival: Ribelli per caso di Vincenzo Terracino, un film originale e divertente che riproduce sullo schermo varie componenti della società italiana attraverso la simpatica ribellione di un gruppo di anziani pazienti, di diversa estrazione sociale, che, costretti a dividere una corsia di ospedale, si alleano per poter sostituire il cibo sciapo dell’ospedale con piatti saporiti; Come si fa un Martini di Kiko Stella, un’opera corale congegnata all’interno di una varietà di brevi storie le cui trame si intersecano con raffinato umorismo; Tornando a casa di Vincenzo Marra, una produzione cinematografica molto convincente in cui, riscattando la lezione neorealista, si parla di pescatori che lottano contro la fame e dello sfruttamento degli immigranti nell’Italia di oggi; L’amore probabilmente di Giuseppe Bertolocci, un film colto che parla dei rapporti tra la finzione, la vita e la finzione nella vita, interpretato brillantemente dalla giovane attrice Sonia Bergamasco, proveniente anch’ essa dal teatro, in cui ha lavorato con Giorgio Strehler, Glauco Mauri, Theodoros Terzopulos e da poco approdata al cinema. Perfetta interprete di voci recitative, Sonia é anche poetessa e ha vinto nel 1997 il “Premio Nazionale di Poesia Marianna Fiorenzi”. Durante il Festival ha avuto luogo il seminario: “Luchino Visconti: innovazione e tradizione/Cinema italiano contemporaneo”, al quale hanno partecipato: Florinda Bolkan, l’unica attrice brasiliana che ha lavorato con Visconti, la quale ha parlato con emozione della sua esperienza, come professionista e come amica, con il regista milanese: il regista Andrea Porporati e gli attori Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni che hanno fatto un’analisi del cinema contemporaneo italiano a partire dalle loro esperienze professionali e il sottoscritto come moderatore e specialista di Visconti. Dall’animato dibattito con il numeroso pubblico, che si è protratto per quasi tre ore, si é concluso che il cinema italiano attuale è vivo, anzi vivissimo. Erede comunque della grande cinematografia italiana, rappresentata appunto da Visconti, Fellini, Antonioni, Rossellini. De Sica, Rosi e così via, dopo trent’anni di crisi produttiva e di ispirazione, il nuovo cinema italiano sta cercando di riconoscersi in un nuovo e diversissimo contesto sociale e politico, con numerose e valide sperimentazioni.
Mosaico Italiano #3
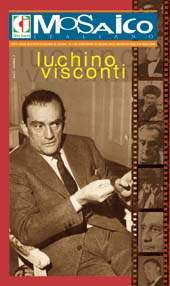
O Barraco? (Helena Parente Cunha/tradução de Brunello De Cusatis e comentários de Annita Gullo)
Il capitalismo? È alle corde perché ha perso la base etica (Francesco Alberoni)
La Bossi-Fini e le morti clandestini (Giusy D'Alconzo)
I cognomi provenienti da nomi personali o individuali (Giuseppe D'Angelo)
L'insegnamento dell'italiano in Brasile (Jaci Correia Fernandes)
L'Umbria, misto di sacro e profano (Milva Scorpioni)
Rina Sara Virgillito: una mistica del novecento (Sergio Romanelli)
L'eredità viscontiana (Alessandro Bencivenni)
Il parlato-scritto nella poesia di Dacia Maraini (Flávia A. Alves Muniz)